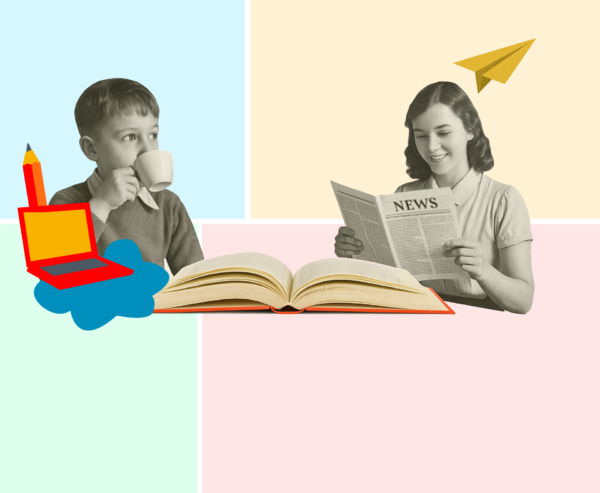Il docente Vittorio Caratozzolo, che nello scorso Meet Film Festival di Roma ha preso parte a un dibattito sull’uso degli audiovisivi a scuola, ci ha raccontato la sua esperienza come project manager cinematografico presso la scuola “Giacomo Bresadola” di Trento.
Come nasce l’idea di portare il cinema in classe?
Ho sempre utilizzato gli audiovisivi, documentari e film, come supporto per l’attività didattica ordinaria, senza trascurare di proporre considerazioni di carattere semiotico-tecnico su tali “testi”, in comparazione con i testi scritti. Nel contempo, mi sono dedicato anche alla scrittura creativa e alla didattica ludica, con il volume Scrivere come Frankenstein. Esperimenti di chirurgia testuale (La Meridiana, 2007) e con il laboratorio intitolato “La Fabbrica dei Giochi”, con cui per una decina d’anni ho coordinato i lavori di progettazione e realizzazione di giochi didattici con numerose classi della secondaria di I grado del mio istituto.
Entrambe queste modalità sono state presentate anche agli studenti e da essi praticate (individualmente o in piccolo gruppo) come attività di osservazione, progettazione e realizzazione di strumenti didattici applicate a diverse discipline, il cui prodotto era inizialmente meno importante dell’utilità formativa del processo creativo. La valutazione di questi lavori non si è limitata solo al mio ordinario commento valutativo in qualità di docente, ma di tanto in tanto è stata “affidata” a valutatori estranei, tramite l’iscrizione a concorsi letterari (poesia, prosa, teatro) e per audiovisivi. In sintesi, ho sempre cercato di attivare la capacità di analisi, di interpretazione e di critica di un testo (letterario e non), come base per lo sviluppo dell’abilità di riproduzione e di creazione di testi (letterari e non).
In che modo il cinema può integrarsi in ottica interdisciplinare alle attività scolastiche? Le ricadute positive dei vostri progetti toccano anche aspetti formativi e psicologici più ampi.
Come insegnante di Italiano, Storia e Geografia, ho sempre avuto un campo d’indagine e di apprendimento molto ampio su cui contare per trarne spunti e ispirazione utili alla realizzazione di testi audiovisivi, con un’attenzione costante per la parte scritta (progettuale, didascalica, narrativa). Unitamente al “vedere cinema”, “fare cinema” ha consentito ai miei studenti e a me di sperimentare una straordinaria varietà di competenze e abilità molto concrete, in quanto finalizzate alla realizzazione di un prodotto finale. La preoccupazione per lo svolgimento del programma è stata attenuata valutando e calibrando attentamente gli obiettivi della didattica per abilità e competenze, e la possibilità di inserire nei prodotti dell’attività cinematografica anche una utile selezione di contenuti disciplinari.
Tramite la partecipazione a concorsi (letterari, cinematografici), gli studenti sono entrati nel mondo reale, dove successo e fallimento costituiscono due risultati possibili, egualmente necessari ed educativi, che in ogni caso spingono ad esercitare la propria capacità di “intervento” nel mondo extrascolastico, estendendo a grandi distanze il proprio personale (individuale, collettivo) raggio comunicativo ed espressivo: i contenuti artistici, espressivi e critico-sociali di una poesia, di un racconto o di un cortometraggio “non vincente” sono comunque stati considerati e valutati al di fuori della sfera protettiva e rassicurante dell’ambiente scuola-famiglia.

Come si scelgono i temi da sviluppare con la classe? I feedback sulla realizzazione dei vari cortometraggi parlano di soddisfazione di portare a termine un progetto, ma anche di divertimento condiviso.
La “programmazione ordinaria” e l’attualità offrono infiniti spunti di riflessione e di trattamento ai fini di una progettazione creativa (di cui la discussione e scrittura costituiscono quasi sempre il punto di partenza). La ricaduta positiva dipende anche dal consenso che si riesce a creare in ambito scolastico, in sinergia con la dirigenza, le famiglie e i consigli di classe. L’autostima degli studenti aumenta notevolmente se essi riscontrano l’approvazione di tali enti educativi. La consapevolezza critica ed autocritica sono obiettivi educativi primari, cui un approccio ludico-creativo offre una modalità di alleggerimento del peso psicologico di tali obiettivi formativi.
Secondo lei, se la scuola italiana dovrebbe integrare meglio nella didattica questo tipo di attività formative? Perché?
Personalmente ho potuto contare quasi sempre solo sul lavoro di squadra con gli studenti, considerando che “lavorare in squadra” a scuola è uno degli obiettivi formativi, non garantito in partenza. Peraltro, una classe scolastica non è una troupe di professionisti legati tra loro da contratti e retribuzioni con conseguenti doveri e obblighi; il tempo-scuola e lo spazio-scuola hanno orari, campanelle, gravosi limiti di risorse.
Il corpo docente è costituito da professionisti con differenti interessi, convinzioni, formazione, mentalità; i dirigenti devono bilanciare le numerose istanze provenienti dal mondo scolastico ed extrascolastico… tutto ciò può spingere all’isolamento, a lavorare ognuno “per sé”, cercando la minima e necessaria collaborazione degli studenti, i quali devono essere partecipi e mediamente contenti del lavoro che si propone.
Gli studenti come gli adulti sono “consumatori” di tv e cinema, con tutte le relative varianti web, Tik Tok, Instagram: essere spettatori passivi non significa essere utenti consapevoli. Un’ampia competenza semiotica passiva e attiva, su ogni tipo di testo, compresi gli invadenti audiovisivi, a mio avviso è un obiettivo primario per la scuola contemporanea, e la pratica del vedere-fare cinema, associata sinergicamente alla pratica della lettura-scrittura-ascolto-produzione orale, può cercare di favorire il perseguimento di tale obiettivo.
L’approccio con il cinema, a partire dall’immagine in movimento e i relativi suoni, riporta l’esperienza personale a ritroso attraverso lo sviluppo di fotografia, pittura / scultura (tridimensionale), disegno, fino alle basi dell’osservazione, considerazione, valorizzazione e interpretazione di dettagli e contesti, nella loro mutua, complessa e significativa interazione semiotica. Guardando / facendo cinema si impara a guardare non solo un manufatto umano nel suo insieme e nei suoi particolari, ma anche l’universo circostante nella sua complessità.
Lavori realizzati con le classi
- 3A (2023 24) https://www.youtube.com/watch?v=tSwt6Ey2xno&list=PLSk4xrxmrMyu3J93VEZ8G1FCrK3qh9Oae
- 2A (2022-23) https://www.youtube.com/watch?v=mpOZO0GpYjk&list=PLSk4xrxmrMyuteTkBZWSDmrmOqyBiVqAc
- 1A (2021-22) https://www.youtube.com/watch?v=gnGQNbHgP8o&list=PLSk4xrxmrMyvuQiDqtQmEj-d_vKsBn1zZ
- 1 A (2021-22) serie CORONAVIRUS https://www.youtube.com/watch?v=neM7MUSjgdc&list=PLSk4xrxmrMyvJ1IS_6fwA7tww_-ZGuBin
- 3A (2020-21) https://www.youtube.com/watch?v=gytCrlzj5Fk&list=PLSk4xrxmrMytPUkmrB7NSyCCegXjUzinZ

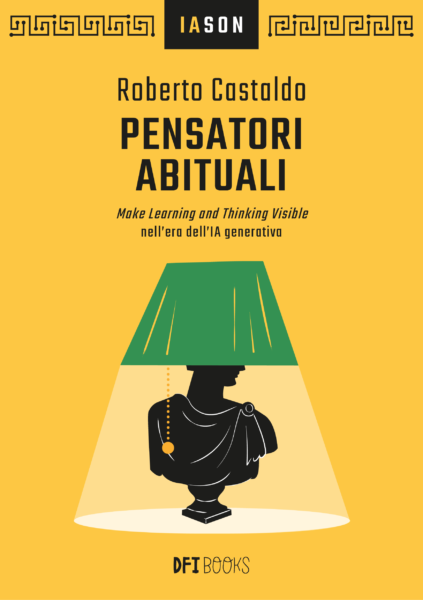





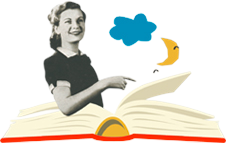

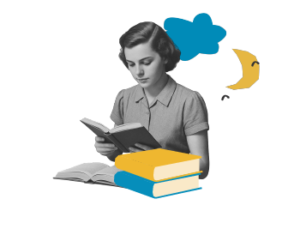


 Vittorio Caratozzolo
Vittorio Caratozzolo 




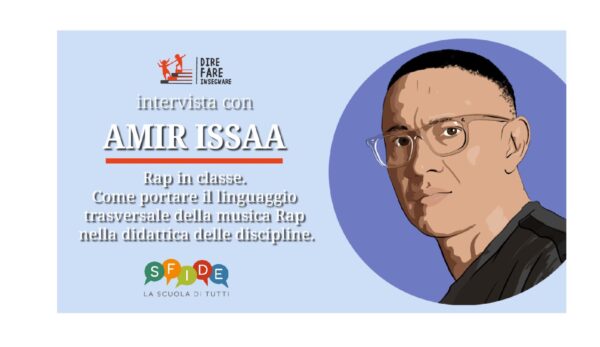
 Amir Issaa
Amir Issaa 
 Angela Schisa
Angela Schisa 

 Marta De Marinis
Marta De Marinis 
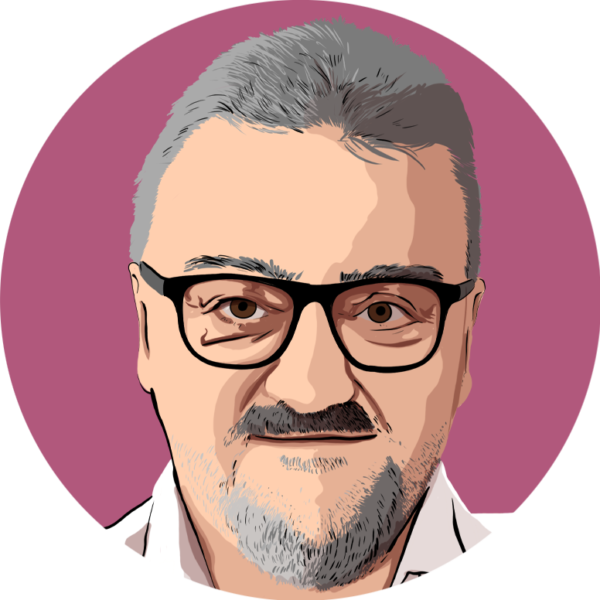 Roberto Castaldo - DFI Books
Roberto Castaldo - DFI Books