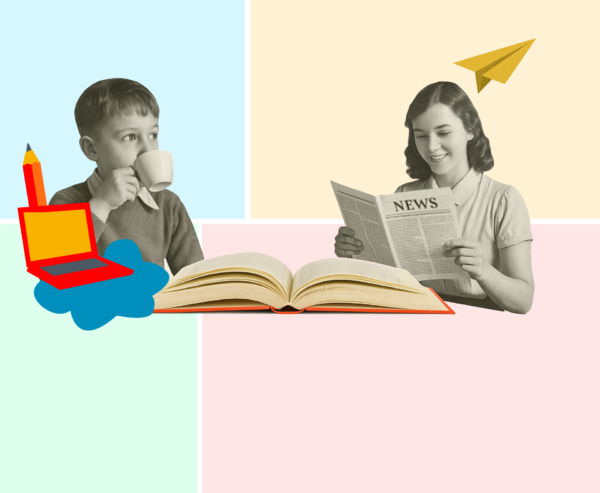La Giornata Internazionale degli studenti e delle studentesse si celebra ogni anno il 17 novembre dal 1939. È una ricorrenza con una forte valenza storica e politica, nata per ricordare la resistenza studentesca contro l’oppressione e per riaffermare il ruolo di studenti e studentesse nella difesa della democrazia, della libertà e dei diritti civili.
Oggi la giornata è riconosciuta e celebrata in molti Paesi del mondo come occasione per rivendicare il diritto all’istruzione libera, inclusiva e di qualità e per sottolineare il ruolo dei giovani e delle giovani come motore di cambiamento sociale e politico.
La partecipazione giovanile sul clima dentro e fuori la scuola
La scuola è il primo spazio in cui impariamo a leggere il mondo, ma anche il luogo in cui possiamo cominciare a cambiarlo.
Attivarsi sui temi ambientali a partire dai banchi di scuola significa trasformare la conoscenza in responsabilità, e l’educazione in pratica democratica. Significa capire che la crisi climatica non è solo un problema scientifico, ma una questione di giustizia, equità e diritti.
L’attivazione studentesca sui temi climatici è educazione alla cittadinanza, è giustizia climatica che parte dal basso, è la possibilità di immaginare insieme un mondo diverso e di cominciare a costruirlo, giorno dopo giorno, a partire dalle aule.
Nuove forme di sapere e competenze
La crisi ambientale che stiamo vivendo, con al centro i cambiamenti climatici, richiede nuove forme di sapere e di fare, ma anche di sentire e decidere. Non bastano le competenze tecniche — pure fondamentali — legate alle scienze ambientali o alle tecnologie: servono competenze trasversali e sociali, come la capacità di collaborare, di leggere la complessità, di partecipare a processi decisionali, di prendersi cura dei beni comuni.
In questo senso Luigina Mortari propone un rinnovamento culturale che mette in discussione i paradigmi esistenti di consumo e interazione con l’ambiente. Questa trasformazione, che la Mortari definisce Umanesimo ecologico, richiede una formazione che non solo impartisca conoscenze scientifiche, ma anche promuova un pensiero critico e teoretico, essenziale per affrontare le complessità dei problemi ambientali. Lei vede la scuola come un luogo cruciale per questa trasformazione, dove si coltiva il pensiero e si preparano i cittadini e le cittadine a prendere decisioni informate e responsabili.
Educare alla crisi climatica significa quindi educare alla cittadinanza attiva, formare persone capaci di collegare le scelte individuali alle responsabilità collettive, e di tradurre i saperi in azione. Significa coltivare competenze di giustizia: comprendere le disuguaglianze ambientali, riconoscere i diritti delle generazioni future, dare voce a chi oggi è più colpito dalle conseguenze della crisi.
Le giovani generazioni stanno già mostrando queste capacità, dentro e fuori le aule. Compito della scuola è valorizzarle, sostenerle e metterle in rete, affinché la conoscenza diventi partecipazione e la partecipazione diventi cambiamento.
Nell’articolo pubblicato lo scorso mese abbiamo approfondito alcune proposte didattiche e metodologie utili a favorire ed esercitare il protagonismo giovanile dentro e fuori la scuola: le assemblee per il clima, la scienza aperta, l’educazione cooperativa.
Il programma didattico che, come associazione, abbiamo elaborato e portiamo nelle scuole pone studenti e studentesse al centro del processo conoscitivo. E lo fa in un triplice senso. Gli studenti e le studentesse, infatti:
- vengono posti al centro della relazione educativa, per superare il modello trasmissivo in cui il sapere scorre in una sola direzione — dall’insegnante al discente — e per riconoscere che l’apprendimento è un processo dialogico, partecipato e co-costruito.
- non sono solo destinatari, ma produttori di conoscenza. In questo modo la scuola si trasforma in luogo di ricerca collettiva, dove si sperimenta, si osserva, si documenta e si restituisce valore al sapere situato nei contesti locali. Attraverso pratiche di scienza aperta ragazze e ragazzi possono contribuire direttamente alla generazione di dati e conoscenze utili alla comunità.
- sono protagonisti di cambiamento a partire dalla scuola e dalle comunità educanti come attori principali in grado di attivare la comunità tutta nella sperimentazione di soluzioni collettive per affrontare la crisi ambientale e i cambiamenti climatici.

La scuola come polo ambientale
Le scuole di ogni ordine e grado possono rappresentare un riferimento per studenti e studentesse e per le comunità educanti e luoghi di formazione alla cittadinanza ecologica. Possono quindi divenire, oltre che poli culturali, anche poli ambientali.
Ma per far questo la scuola deve in primo luogo attrezzarsi e divenire, anche strutturalmente, esempio di un modello alternativo di consumare, vivere e relazionarsi con l’ambiente.
Eppure, il patrimonio edilizio scolastico italiano è spesso datato e inefficiente: secondo i dati del Ministero dell’Istruzione e dell’ISPRA, più del 55% degli edifici scolastici è stato costruito prima del 1976, quindi prima delle prime norme sull’efficienza energetica e la sicurezza sismica. Molte strutture hanno impianti obsoleti, scarso isolamento termico, consumo elevato di energia e scarsa qualità dell’aria interna.
All’interno delle scuole italiane è difficile parlare di comportamenti collettivi che possano mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Servono politiche che investono in questo settore.
L’efficientamento energetico non è solo un progetto tecnico o edilizio, ma anche un processo educativo e civico. Ogni intervento può diventare occasione per coinvolgere la popolazione scolastica in percorsi di educazione ambientale in grado, ad esempio, di monitorare i consumi e le abitudini utilizzando la scuola come laboratorio di ecologismo reale, dove teoria e pratica si incontrano.
Giustizia intergenerazionale
L’attivazione giovanile sul clima ha introdotto nel dibattito internazionale il tema della giustizia intergenerazionale, ovvero la responsabilità che le generazioni presenti hanno verso quelle future.
L’idea di giustizia intergenerazionale parte da un principio semplice ma radicale: le azioni di oggi determinano le possibilità di vita di chi verrà dopo di noi. Riguarda quindi la distribuzione equa non solo delle risorse, ma anche dei diritti, dei rischi e delle opportunità nel tempo.
Nel contesto climatico, questo significa che le scelte politiche, economiche e produttive compiute nel presente non dovrebbero compromettere la capacità delle generazioni future di vivere in un ambiente sano e sicuro.
È un’estensione temporale della giustizia ambientale: se quest’ultima riguarda chi subisce oggi gli impatti della crisi (spesso i più poveri e vulnerabili), la giustizia intergenerazionale riguarda anche chi li subirà domani.
I movimenti giovanili per il clima hanno riportato al centro la giustizia intergenerazionale come questione politica e morale. Quando le piazze gridano «non rubateci il futuro», non si tratta di una metafora, ma di una denuncia di un’ingiustizia temporale concreta.
La giustizia intergenerazionale, però, non è solo una promessa di equità futura, ma una richiesta di partecipazione presente: dare voce ai giovani e alle giovani, includere la prospettiva del lungo periodo nelle politiche pubbliche, e considerare il futuro come uno spazio di diritti, non di sacrifici inevitabili.

L’importanza degli spazi di democrazia nelle scuole
Negli ultimi anni si è aperto un capitolo controverso nella relazione tra movimenti ecologisti e istituzioni: azioni spesso simboliche, pacifiche e non violente – molto spesso compiute da giovani attivisti e attiviste – vengono trattate come minacce alla sicurezza, alimentando una narrazione che delegittima l’impegno civile e riduce la protesta a questione di ordine pubblico.
Questo fenomeno riguarda anche il mondo della scuola: secondo molti, le recenti riforme sono un tentativo di restringere gli spazi di autonomia e libertà educativa. Una visione incentrata sui contenuti disciplinari si traduce spesso in un approccio punitivo verso il dissenso studentesco: sospensioni fino a tre settimane per chi occupa gli istituti, rilievo del voto in condotta come strumento di esclusione e bocciatura. Una direzione che sembra anteporre la repressione al dialogo, l’autorità alla crescita critica.
In un contesto in cui chi prende parola viene silenziato o punito, la partecipazione delle giovani generazioni diventa ancora più cruciale. Sono proprio loro, con la loro capacità di immaginare futuri diversi e di chiedere responsabilità, a mantenere viva la democrazia e a spingere la società verso un cambiamento ecologico reale.

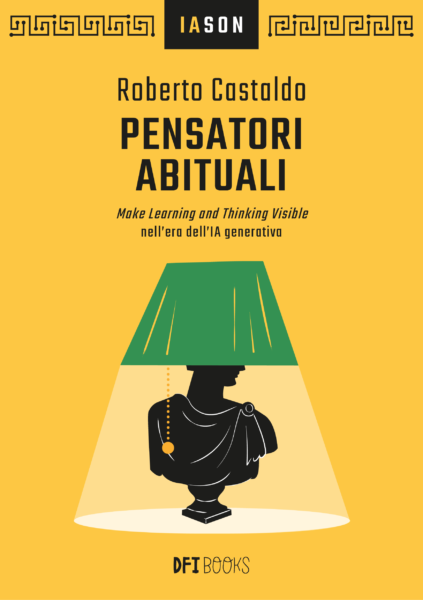





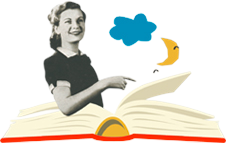

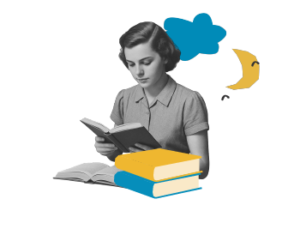


 Nicole Marcellini
Nicole Marcellini 





 Giuliana Disanto
Giuliana Disanto 
 Angela Schisa
Angela Schisa 

 Marta De Marinis
Marta De Marinis 
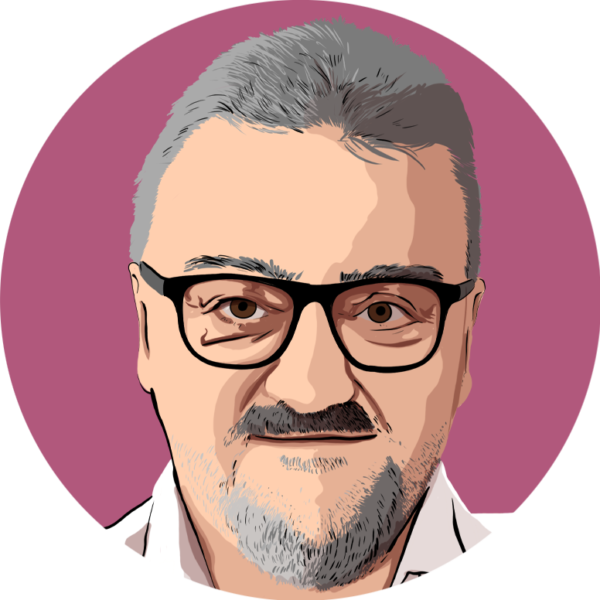 Roberto Castaldo - DFI Books
Roberto Castaldo - DFI Books