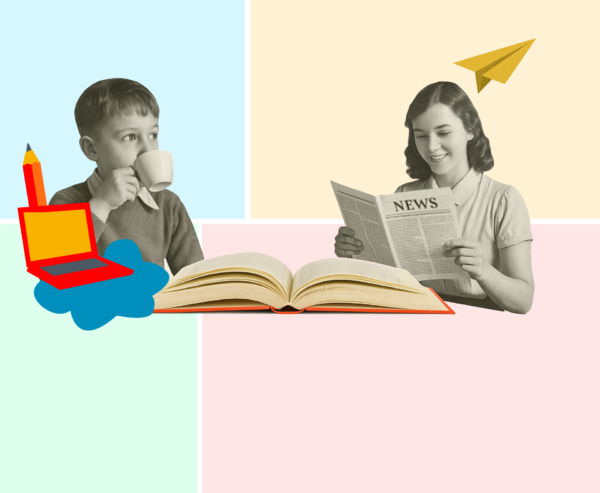La “scoperta” della plusdotazione
In Italia, sui giornali, sui magazine e sui media che parlano di scuola e didattica, negli ultimi mesi sono comparsi molti articoli e servizi sugli studenti plusdotati: questo perché, finalmente, si sta ponendo attenzione a questo argomento, noto in realtà da più di duecento anni.
Storicamente, infatti, il termine “gifted” è stato usato per la prima volta nel 1869 dal naturalista e statistico inglese Sir Francis Galton per indicare gli adulti con un’intelligenza sopra la media.
La necessità di adattare la didattica alle caratteristiche peculiari della plusdotazione è nata parallelamente a questa scoperta e, già più volte segnalata in Europa nell’ultima decade dell’Ottocento, è stata attenzionata da diversi psicologi già a inizio Novecento.
Eppure in Italia è un argomento praticamente ancora sconosciuto: nel 2019, poco prima che l’attenzione dell’intero pianeta fosse focalizzata sulla pandemia globale, il Ministero dell’Istruzione fece uscire una Nota Ministeriale a riguardo (Nota Miur 562 del 03/04/2019). In questa nota, studentesse e studenti plusdotati sono riconosciuti di diritto come BES e viene demandata ai docenti la responsabilità di stilare un PDP adatto a rispondere alle loro necessità educative.
Tuttavia, tantissime scuole ed insegnanti sono ancora oggi impreparati o poco formati sull’argomento: molti docenti non sanno riconoscere, tra le file dei loro banchi, i segnali della plusdotazione. Si stima che uno studente plusdotato su cinque abbandoni la scuola perché demotivato e frustrato da una realtà educativa che non solo non lo supporta, ma spesso nemmeno lo riconosce e accetta.

Quando uno studente si definisce “plusdotato”?
Si considera plusdotata una persona che, sottoposta a un test del quoziente intellettivo, ottiene un punteggio più alto della media, a tal punto da essere raggiunta solo da 2 persone ogni 100; possiede quindi un QI superiore a 130 nella scala Wechsler, e 148 in scala Cattel.
Se ci si sofferma sulla definizione stretta di plusdotazione si parla del 2% degli studenti: in media, quindi, uno studente ogni due classi.
La letteratura scientifica sottolinea che bisogna prestare attenzione anche a quella percentuale di studentesse e studenti che si definisce “ad alto potenziale cognitivo”: sono persone che, a un test del quoziente intellettivo, ottengono punteggi di poco inferiori a quelli della plusdotazione, cioè un QI superiore a 120 punti Wechsler o 132 scala Cattel, e sono individui soggetti a bisogni educativi simili a quelli degli studenti plusdotati.
L’insieme di studentesse e studenti plusdotati e ad alto potenziale cognitivo rappresenta in totale circa il 10% della popolazione studentesca, ossia uno studente ogni dieci: questo significa che, nonostante oggi non riusciamo a riconoscerli e intercettarli tutti, ce ne sono in media circa due per classe.
Perché è importante riconoscere la plusdotazione
Il termine “plusdotato” spesso porta con sé aspettative non veritiere per gli insegnanti, e si accompagna a stereotipi ben radicati e diffusi in tutta la popolazione: questo è il motivo principale per cui spesso non riconosciamo studentesse e studenti plusdotati.
Un alto punteggio del quoziente intellettivo non significa che la studentessa o lo studente plusdotato sia, come la parola sembra suggerire, uno studente brillante, con un’incredibile intelligenza manifesta, una condotta integerrima e una matura vita affettiva e relazionale. Anche se è questo quello a cui pensiamo quando ci chiediamo se tra i nostri studenti ve ne sia qualcuno, in verità non sono solo queste le caratteristiche che dobbiamo cercare in classe per individuali.
Il primo motivo per non farlo è che la plusdotazione non è solo un alto quoziente intellettivo, per quanto venga individuata tramite un test che misura proprio quello; nella realtà essa è una poliedrica presenza di caratteristiche cognitive peculiari, che non sempre insieme si manifestano come un comportamento o un intelletto percepiti come “superiori”. In qualità o in quantità, nei risultati scolastici o nella vita di tutti i giorni, non sempre lo studente plusdotato eccelle.
Il secondo motivo è che un alto punteggio al test del quoziente intellettivo non indica un’intelligenza e delle capacità già sviluppate, mature e in atto, ma piuttosto indica un potenziale che ha bisogno, come per qualsiasi altra studentessa o studente, di guida, attenzioni e cure per svilupparsi e trasformarsi in un talento manifesto.
Tutto questo rischia non solo di rendere gli studenti invisibili agli occhi degli insegnanti, ma di indurre spesso anche le persone adulte a guardarli con una involontaria resistenza, rendendo impossibile sia individuarli sia applicare le misure didattiche personalizzate di cui avrebbero bisogno. Un po’ quello che è successo all’inizio con gli studenti con DSA.
Non conoscere approfonditamente le caratteristiche reali di queste studentesse e di questi studenti porta a etichettare i loro comportamenti come difficoltà comportamentali, fragilità attentive, svogliatezza, demotivazione, oppositività o eccentricità.

Segnali di plusdotazione
Ogni studente plusdotato è diverso dagli altri studenti plusdotati. La giftedness è accompagnata da un vasto insieme di caratteristiche, che possono essere più o meno presenti in ogni studente plusdotato e più o meno evidenti quando lo osserviamo. Quanto si vede della plusdotazione tra i banchi di scuola dipende, inoltre, anche da quanto la bambina o il bambino ha imparato a mascherare la sua vera natura, magari in risposta ad ambienti ostili o in preda all’imbarazzo del sentirsi diverso dagli altri. Per questo non sempre tutti i segnali di plusdotazione sono evidenti o presenti in una persona gifted e c’è bisogno della piena collaborazione di tutti – scuola, famiglia e psicologi professionisti – per individuarli e dare loro le corrette attenzioni.
Tipicamente, la giftedness è accompagnata a una grande sete di conoscenza, una grande curiosità e una grande inclinazione a porsi domande; questo, in una studentessa o in uno studente, si manifesta con un’inclinazione a porre tantissime domande all’insegnante, più o meno collegate all’argomento di cui si sta realmente parlando in classe.
Sono spesso studenti con capacità straordinarie di memorizzazione, per cui appaiono come incredibili conoscitori di argomenti che normalmente non sono tra i primi interessi dei loro coetanei. Imparano più velocemente degli altri. Nel ragionamento possono saltare passaggi logici, o arrivare a soluzioni creative ed originali di un problema o di un esercizio, grazie a una caratteristica tipica della plusdotazione nota come “pensiero divergente”. Possono mostrare talenti già sviluppati in alcune materie, mentre in altre possono avere un rendimento nella norma o essere anche in difficoltà, specie se la plusdotazione è accompagnata da altre neurodivergenze, come ad esempio la dislessia o l’ADHD.
Sono studenti che, a differenza del tipico studente brillante perché si applica molto nello studio, spesso dimostrano capacità avanzate di comprensione e collegamento: corrono avanti negli argomenti, ponendo domande che attestano riflessioni avanzate sul tema di cui si sta discutendo e inaspettate capacità di approccio interdisciplinare al tema trattato, difficilmente riscontrabili nei compagni. Spesso sono molto sensibili a tematiche di giustizia, etica o morale, fanno domande su temi come la morte e l’universo e sostengono in modo appassionato le loro tesi. Possiedono un dizionario ampio e forbito, con capacità di sintassi sia scritta che orale molto sopra la media; possono essere dotati di un livello di humor più avanzato rispetto a quanto ci aspettiamo dalla loro età anagrafica.
Tuttavia, essere una studentessa o uno studente plusdotato non significa possedere sempre e solo una combinazione di tratti positivi: le loro caratteristiche cognitive possono essere accompagnate da conseguenze inaspettate nella sfera del comportamento o capacità emotive e relazionali inferiori a quelle che ci aspetteremmo per la loro età cronologica, anche molto in dissonanza con le loro alte capacità intellettive (in questo caso si parla di dissincronia).
Questo “dark side” della plusdotazione, di cui parleremo nel prossimo articolo, può far appariregli studenti plusdotati come immaturi, ingestibili e caratteriali, e metterci in difficoltà non solo nel riconoscerli per quello che davvero sono ma anche, come vedremo, nel gestirli o trovare le giuste strategie didattiche per accompagnarli nel loro percorso scolastico.
Bibliografia
- Daniela Lucangeli (a cura di), Gifted, la mente geniale, Giunti Scuola.
- Lara Milan (a cura di), Lo sviluppo del talento e dell’alto potenzial, Erickson.
- Federica Mormando, Altissimo potenziale intellettivo, Erickson.
- Maria Assunta Zanetti (a cura di), Bambini e ragazzi ad alto potenziale, Carocci.

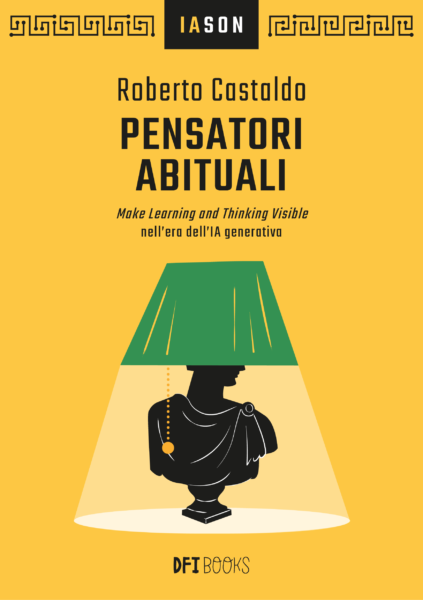





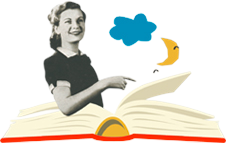

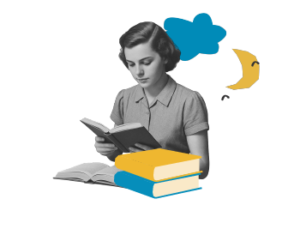


 Silvia Giordano
Silvia Giordano 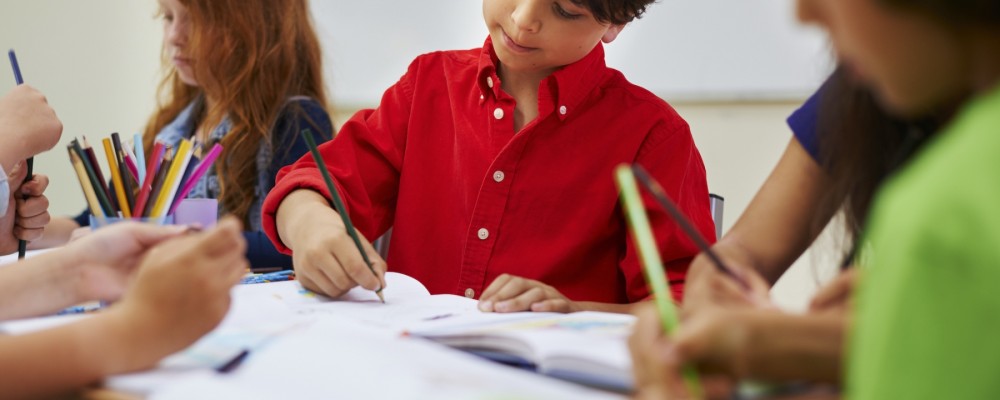




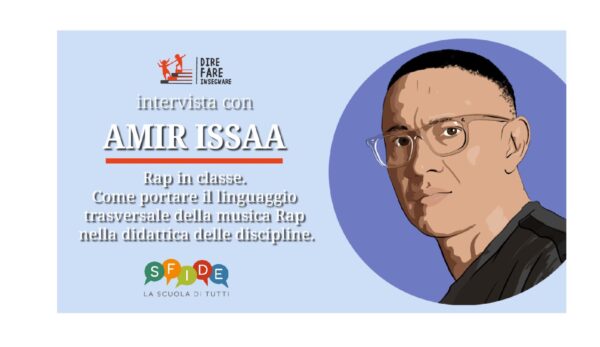
 Amir Issaa
Amir Issaa 
 Angela Schisa
Angela Schisa 

 Marta De Marinis
Marta De Marinis 
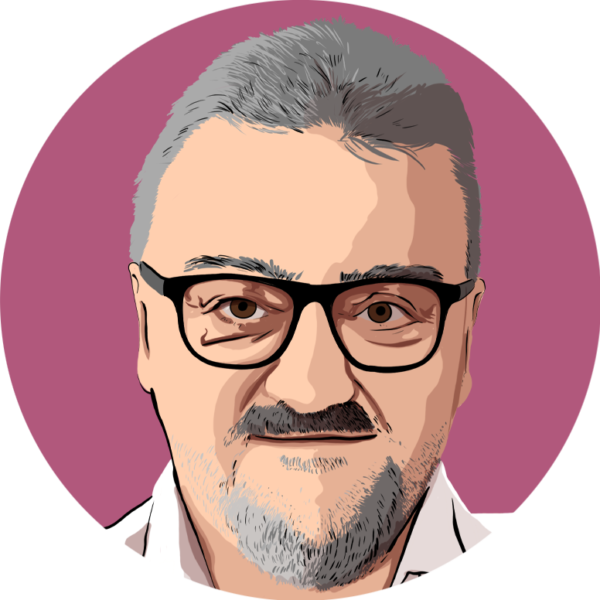 Roberto Castaldo - DFI Books
Roberto Castaldo - DFI Books