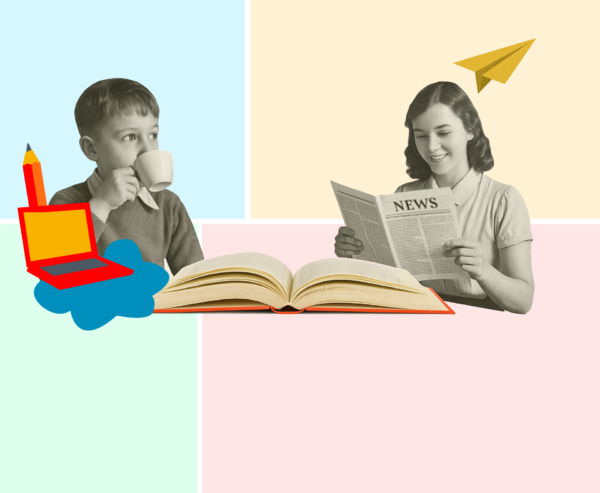C’è chi sa “tutto” sulla poesia (il fare poetico, la letteratura poetica, la psicologia e la sociologia della poesia…) e chi non ne sa né vuol saperne nulla, anche perché pensa o crede di non averne bisogno. Un’ampia fascia di popolazione, forse, ne sa o crede di saperne qualcosa e, alla domanda “a che cosa serve la poesia?” prova a rispondere in base alla propria esperienza e competenza.
La poesia, una faccenda di libri?
Navigando in rete si trovano le risposte, tra mille altre, di due poeti. Laura Garavaglia parla di “inutile bellezza della poesia”, di poesia come “genere letterario di nicchia, trascurato dalla gran parte dei lettori e, di conseguenza, dalla maggior parte delle case editrici, perché non finalizzato all’utile, al profitto”. Davide Rondoni dice: “La poesia, del resto, non è mai stata una faccenda di libri. L’hanno fatta passare per una cosa di libri solo di recente, e hanno sbagliato. […] Né Dante né Omero e nessun poeta fino a secoli recentissimi si è mai posto il problema dei libri di poesia. Esisteva la poesia, come esiste ancora, spesso recitata, mormorata, detta ad alta voce, e oggi replicata con mille tipi di diffusione, dalla radio a Internet. Parole e voci umane che nascono da momenti di esperienze personalissime, parole accese che sono in grado, a differenza di tantissimi altri tipi di parole, di essere significative per persone lontane nel tempo e nello spazio”.
Nel mondo della scuola e nell’extra-mondo in cui essa galleggia come un galeone, sballottato dalle tempeste politiche e mediatiche, su rotte talora impervie eppure tracciabili e rintracciabili, quasi tutti dovrebbero comunque essere d’accordo sulla necessità e sull’importanza di insegnare/apprendere la poesia fin dall’infanzia. Nel contenitore delle “cose da insegnare”, in realtà, lo spazio per la poesia si restringe sempre più, sotto la pressione delle “cose imprescindibili da insegnare”, le quali spesso hanno una utilità in termini economici molto più chiara rispetto alla poesia.
Un approccio che personalmente mi è molto caro è correlato alla didattica ludica, di cui ho trattato in questo articolo e altrove. Resta naturalmente Gianni Rodari il faro della nostra navigazione nei mari della poesia, insieme ad altri ben noti e pronti ad illuminarci nei momenti bui del percorso, senza escludere il logofunambolico Bergonzoni, né il “ricettario” di Brugnolo e Mozzi (da me scoperto più recentemente).
Imparare a leggere per imparare a scrivere
Prima ho parlato di “esperienza” e “competenza”. Posto il testo poetico al centro dell’asse comunicativo mittente-destinatario, mi sembra evidente che la soggettività del primo (correlate a individuo, tempo e spazio) permei il testo in maniera molto relativamente intelligibile per il soggetto-destinatario (altrettanto unico nella sua individualità, legata al suo tempo e al suo spazio). Dalla mia esperienza e competenza (linguistica, semiotica, interpretativa, affettiva), come io-insegnante e destinatario autoproclamato (ho presumibilmente scelto io cosa leggere), dipende l’interpretazione e forse l’apprezzamento di un testo poetico (vale per la poesia, ma anche per altri generi).
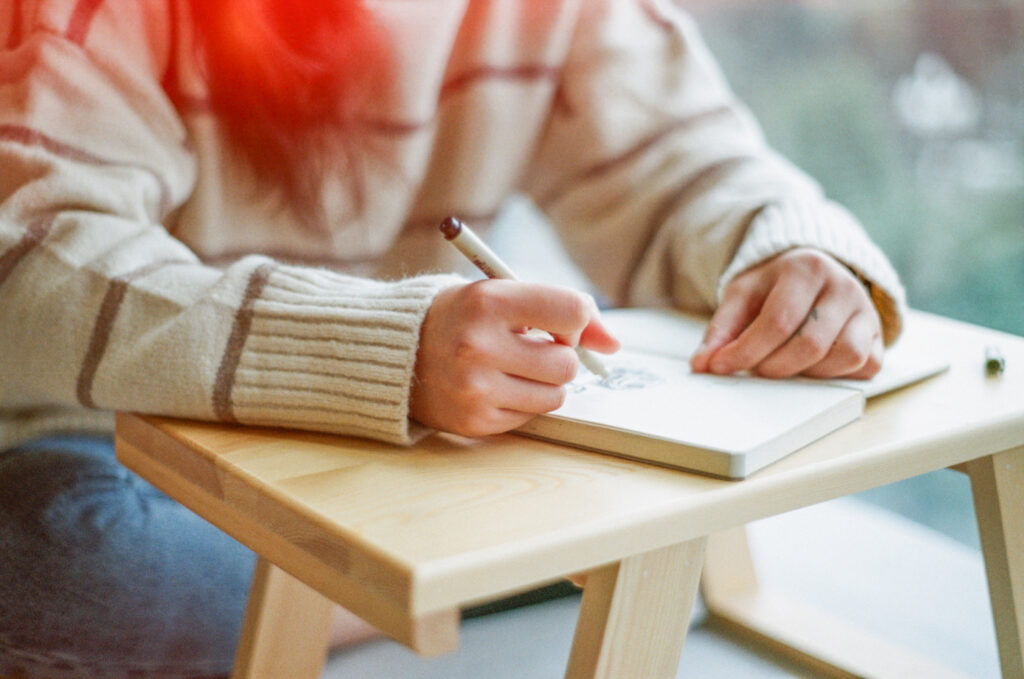
Cosa accade e come accade, se chi sceglie il testo è il docente, e il destinatario è ogni singolo studente? La prima cosa che si può constatare è l’asimmetria di esperienza e di competenza tra i due soggetti, considerando che il mittente storico del testo poetico viene in qualche modo emarginato da questo scambio comunicativo. Probabilmente siamo tutti d’accordo sul fatto che per scrivere poesia (sempre che lo si ritenga opportuno, utile e necessario) occorre leggere poesia. Prima leggere e poi scrivere. Sembra ovvio. In questo schema chiuso si rischia di dimenticare però che la scuola non è un sistema chiuso, e che le esperienze/competenze dei destinatari si formano in buona parte fuori dalla scuola e non solo grazie alla comunicazione in famiglia, ma anche in conseguenza dell’esposizione (gramscianamente di impatto pedagogico, ma caotica e non didatticamente strutturata) alla lingua dei media, TV e strumenti digitali in primis.
Questa concomitanza di modelli linguistici, principalmente sperimentata in modo passivo dai giovanissimi destinatari, va a formare il repertorio di esperienza, anche poetica, su cui si innestano la didattica della poesia a scuola e lo stimolo alla produzione poetica, non di rado in competizione e in contrapposizione. In sintesi, la centralità di famiglia e scuola nell’educazione e nella formazione dei futuri adulti è da decenni ormai in nettissima e difficoltosa competizione con un’Idra proteiforme le cui infinite teste promuovono senza pause modelli culturali e di comportamento, anche effimeri, che appaiono egualmente utili, opportuni e autorevoli a chi difetta di esperienza e competenza nello sceglierli, valutarli e assimilarli.
Non ho scritto “egualmente piacevoli”, perché va da sé che nel supermarket h24 dell’informazione i futuri adulti scelgono in base ai loro bisogni primari, occultamente persuasi di essere liberi di farlo, mentre in famiglia e soprattutto a scuola talora si vedono o si credono costretti a subire scelte e modelli che altrimenti non sceglierebbero autonomamente. Insegnare poesia, un lavoro arduo.
Il “gioco” della poesia
Fin qui la parte riflessiva di questo mio contributo. Quel che vorrei raccontare nella seconda parte è come e cosa ho fatto io nei miei anni di insegnamento per introdurre la poesia nell’orizzonte di interesse dei miei alunni di scuola secondaria di I grado, anche in modo maieutico. Di sicuro, rodarianamente, ho agito sulla scia di egregie attività svolte alle primarie dagli alunni (ecco la maieutica): giocare con le parole, per creare testi divertenti, strani, talora poetici, anche se non percepiti come tali (ecco prevalere il deficit di esperienza e competenza).
La necessità di ricorrere al gioco per richiamare all’attenzione e all’impegno i destinatari didattici mi è divenuta urgente in Svizzera, quando insegnavo Italiano nei Corsi integrativi di Lingua e Cultura italiana, organizzati dal Ministero degli Affari Esteri. A dir il vero, sin da bambino ho sempre praticato il gioco linguistico, nato o appreso spontaneamente in situazioni scolastiche ed extrascolastiche: dalle filastrocche con i cognomi dei compagni di calcio, alle lettere per amici con scherzi e giochi di parole. Mentre preparavo la mia seconda tesi di dottorato, in Iberistica, per riposarmi dalle fatiche della scrittura seria scrivevo saggi su falsi d’autore, riversati poi in Francesco De Santis. Parastoria della letteratura italiana. La fantasaggistica e l’impero del verosimile (Guida, 2006), seguito da altre opere generate dalla stessa attitudine ludica.
Che cosa significa tutto ciò? Nelle mie intenzioni, che per insegnare non solo è necessario leggere la poesia (come la narrativa e il teatro), ma anche in qualche modo praticarla, sia seriamente che “per gioco”. La parola “gioco” evoca inoltre la competizione. Tornato in Italia nel 2003, nei primissimi anni in una Scuola secondaria di I grado trentina, iniziai a rivolgere la mia attenzione ai concorsi letterari, cui di tanto in tanto partecipavo personalmente. Qualche anno dopo iniziai a programmare la partecipazione dei miei alunni ai concorsi letterari per ragazzi presenti in Italia e mi imbattei nel Concorso Internazionale di Poesia e Teatro “Castello di Duino”, fondato nel 2010 da Gabriella Valera e Ottavio Gruber. Il Concorso (che purtroppo ha terminato l’attività nel 2024) constava di tre sezioni: poesia individuale; dialogo o monologo teatrale; scuole e progetti collettivi.
Nella mia organizzazione didattica, il progetto precedeva la produzione poetica e teatrale e partecipava dunque autonomamente alla competizione. Ogni anno mi inventai un approccio alla poesia tale da risultare originale e competitivo e nel contempo stimolare la produzione di testi da parte dei miei alunni. Al Concorso 2014-15, il cui tema era “Dopo il viaggio (il viaggio come metafora del cambiamento, ma anche come passaggio, da un luogo all’altro dell’anima, da un mondo a un altro, e poi come momento di ritorno alla riflessione interiore)”, arrivammo primi ex-aequo. Il nostro era stato un lavoro di scrittura, sia collettiva che individuale, inserito in una cornice prestabilita costituita da un incipit e da un explicit uguali per tutta la classe, metafora del destino comune (nascita-morte) di donne e uomini che viaggiano attraverso il tempo, da narrare ognuno/a proprio modo.
Non si trattava esattamente di poesia, ma piacque, e questo ci incoraggiò a perseverare. Nel prossimo articolo potete trovare la descrizione del progetto “Viaggio attraverso le forme metriche”, portato al concorso dell’anno successivo, con spunti per una didattica della poesia che vada oltre le forme tradizionali.
Bibliografia
- S. Brugnolo, G. Mozzi, Ricettario di scrittura creativa, Zanichelli, 2000
- V. Caratozzolo, Scrivere come Frankenstein. Esperimenti di chirurgia testuale, La Meridiana, 2007
- V. Caratozzolo, Processo a Don Giovanni. Accusato di omicidio e tentato stupro nell’opera di L. Da Ponte e W. A. Mozart, Guida Editori, 2009

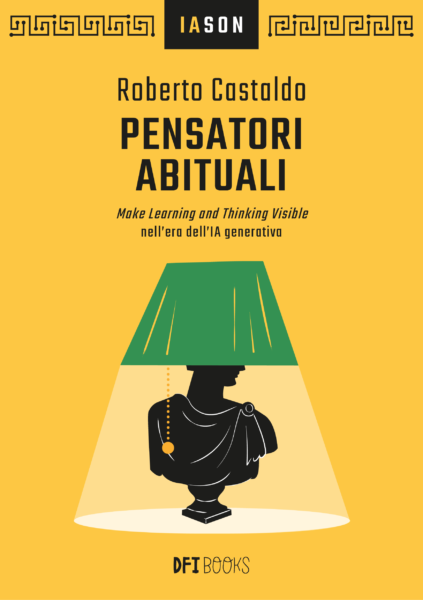





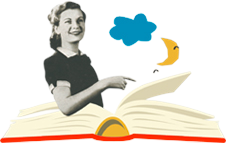

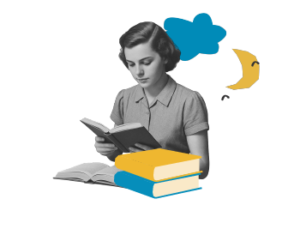


 Vittorio Caratozzolo
Vittorio Caratozzolo 




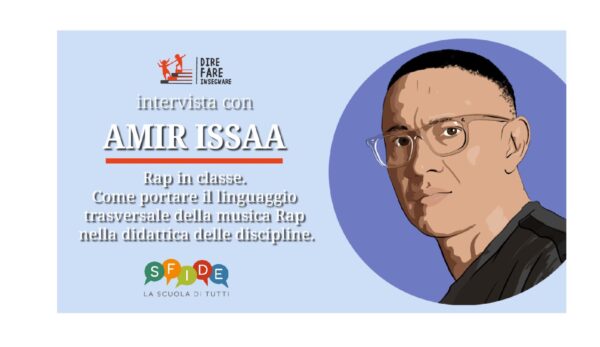
 Amir Issaa
Amir Issaa 
 Angela Schisa
Angela Schisa 

 Marta De Marinis
Marta De Marinis 
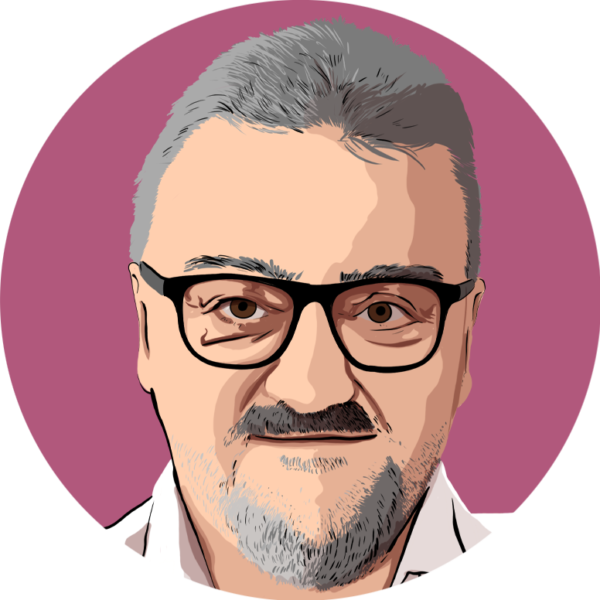 Roberto Castaldo - DFI Books
Roberto Castaldo - DFI Books