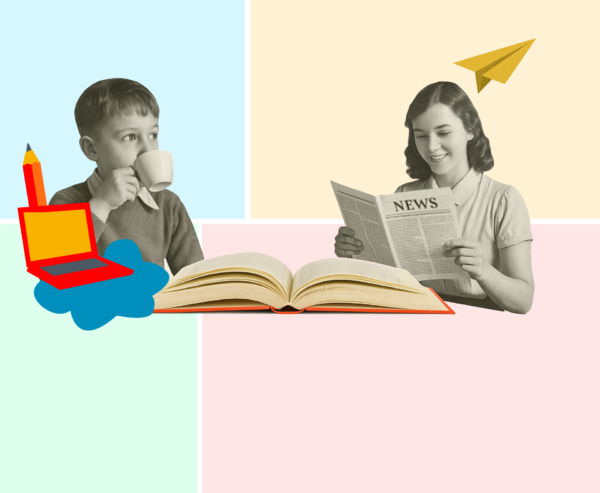L’esposizione orale è una competenza trasversale fondamentale nella Scuola secondaria di primo grado, perché è trasversale a tutte le discipline e prepara gli studenti e le studentesse non solo a sostenere interrogazioni, ma anche a comprendere i contenuti in modo più profondo, a dialogare, a partecipare attivamente alla vita scolastica e sociale. Parlare in modo chiaro, coerente e personale richiede esercizio, metodo e consapevolezza, in quanto coinvolge diverse abilità cognitive e comunicative: pensare in modo ordinato, selezionare le parole, costruire collegamenti, adattare il linguaggio al contesto. In una classe prima, ho progettato un percorso interdisciplinare e graduale incentrato sulla figura di Carlo Magno, utilizzando strumenti come il paratesto, organizzatori grafici, spiegazioni multiple e domande guida a livelli per stimolare una rielaborazione significativa e personalizzata.
Gli obiettivi che mi sono posta sono: sviluppare la comprensione storica attraverso più canali (visivo, verbale, simbolico); stimolare il pensiero critico tramite domande a complessità crescente; favorire l’esposizione orale con mappe, ruoli, analogie e feedback tra pari; rendere l’apprendimento inclusivo, partecipativo e anche divertente.
Le fasi di lavoro
La lezione è partita dall’analisi del paratesto (immagini, titoli, carte geografiche dell’impero) che ha permesso di formulare ipotesi, domande, prime connessioni, stimolando curiosità e coinvolgimento.Dalla comprensione visiva siamo passati alla rielaborazione concettuale. Insieme abbiamo costruito una mappa concettuale collettiva su Carlo Magno, seguita da una mappa individuale, utile come traccia per l’esposizione orale, seguendo il seguente schema:
- biografia e contesto storico;
- le riforme (istruzione, giustizia, religione);
- il rapporto con la Chiesa;
- l’incoronazione a imperatore;
- l’eredità politica e culturale.
L’uso delle mappe ha reso visibile il pensiero, ha aiutato a collegare le informazioni in modo logico e sequenziale, distinguendo ruoli, rapporti e strutture sociali e sono servite anche da traccia per l’esposizione orale.
A partire dai materiali, dopo questa prima fase, sono state proposte agli studenti e alle studentesse, come una sorta di quiz, domande di diversi livelli cognitivi per stimolare l’approfondimento e la costruzione autonoma di senso. Le aree chiave sono state: unificazione dell’Europa, riforma dell’istruzione, relazione con la Chiesa, riforme legali, espansione territoriale.
- LIV 1: definire, elencare, identificare (es. Chi era Carlo Magno?).
- LIV 2: confrontare, riassumere (es. Confronta Carlo Magno con suo padre Pipino il Breve Quali sono state le principali differenze? Riassumi l’impatto del regno di Carlo Magno sullo sviluppo dell’Europa).
- LIV 3: formulare, trarre conclusioni, costruire (es. Valuta l’influenza di Carlo Magno sulla diffusione del cristianesimo in Europa. Quali metodi utilizzò?).
- LIV 4: analizzare, criticare, applicare concetti (es. Analizza gli effetti a lungo termine del regno di Carlo Magno sulla politica e cultura europea moderna. Quali connessioni puoi tracciare? Quali aspetti del suo governo trovi ancora attuali oggi?).
Tutte/i, inclusi gli studenti BES, hanno risposto in forma orale, con l’aiuto delle mappe sviluppate in precedenza.
L’intervista impossibile
Abbiamo poi realizzato un’intervista impossibile, attività che ha permesso a ogni studentessa/studente di mettersi nei panni di intervistatori e di “incontrare” Carlo Magno per porgli le domande preparate in classe (tutte le domande e le risposte sono state scritte in gruppi utilizzando Google Drive). Questa fase ha permesso di rivedere, confrontare e migliorare i testi in modo condiviso. I ruoli erano distribuiti: chi scriveva, chi controllava il contenuto storico, chi curava la forma dell’intervista, in questo modo ogni studente ha potuto contribuire secondo le proprie abilità.
Ecco alcuni stralci dell’intervista.
Giornalista: Lei è considerato il fondatore dell’Europa unita. Ne è consapevole?
Carlo Magno: Assolutamente sì! Sono molto orgoglioso di questo perché il mio sogno era proprio di unificare l’Europa sotto un unico impero. Mi auguro che qualcuno continuerà questo mio progetto.
Giornalista: Tra le tante innovazioni, di quale è più orgoglioso?
Carlo Magno: Sicuramente aver “inventato” la scuola, almeno i miei funzionari e i miei guerrieri sono più informati e preparati. Spero che anche le generazioni future possano beneficiare di questa mia idea.
Giornalista: Che “belva” si sente? (n.d.a. Per questa domanda si sono ispirati al programma televisivo “Belve”).
Carlo Magno: Io mi sento un leone, perché è il re della foresta, o in questo caso dell’impero, simbolo di forza e coraggio, proprio come me.
È stato interessante vederli discutere su alcuni aspetti dell’immagine da creare con l’IA: il ragazzo deve avere un taccuino o un microfono? Deve indossare i jeans? Che postura deve tenere davanti all’imperatore? Il percorso ha, quindi, generato non solo maggiore fiducia, partecipazione e consapevolezza linguistica, perché si è passati da esposizioni frammentarie a narrazioni più fluide, supportate da mappe e collegamenti concettuali ma li ha aiutati a maturare il senso critico e personale dell’argomento. Inoltre, l’uso di spiegazioni multiple ha favorito la comprensione profonda anche da parte delle alunne e degli alunni con difficoltà che hanno apprezzato tale modalità che hanno ritenuto più coinvolgente.
Conclusioni
A fine percorso quali risultati abbiamo raggiunto? Una maggiore familiarità con il lessico storico; la Consapevolezza riguardo l’efficacia delle mappe concettuali che sono diventate uno strumento di studio individuale; infine, il coinvolgimento dell’intero gruppo classe grazie alla diversificazione delle domande, che ha permesso risposte personalizzate.
Il percorso strutturato in questo modo mi ha consentito di approfondire maggiormente alcuni aspetti, dimostrando che la competenza orale può essere costruita in modo graduale, autentico e coinvolgente, mentre l’uso dell’intelligenza artificiale, spesso vista con diffidenza in ambito scolastico, si è rivelato un valido alleato per stimolare l’immaginazione, rendendo il lavoro più accattivante e coinvolgente.
Parlare di storia non significa ripetere date e nomi, che riduce la storia a un elenco da memorizzare, ma imparare a collegare, interpretare, argomentare, raccontare il passato con le proprie parole.


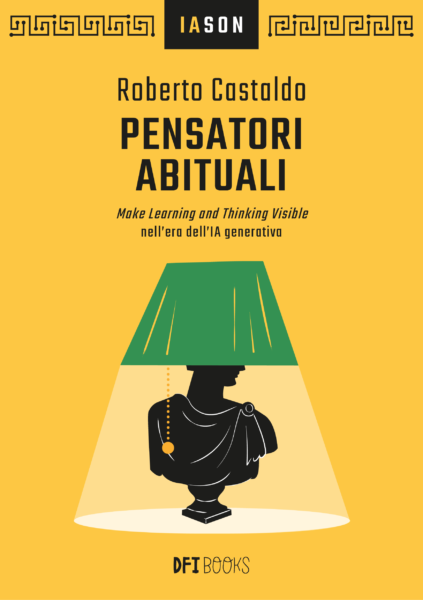





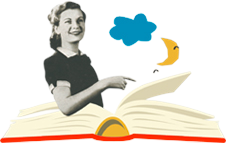

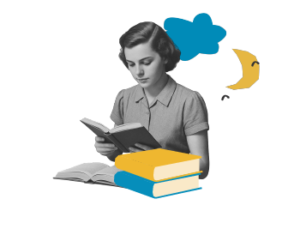


 Francesca Marra
Francesca Marra 




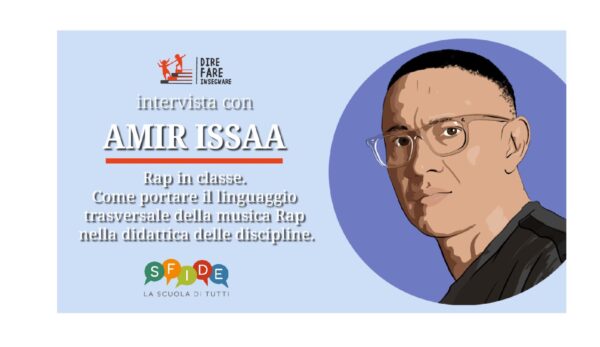
 Amir Issaa
Amir Issaa 
 Angela Schisa
Angela Schisa 

 Marta De Marinis
Marta De Marinis 
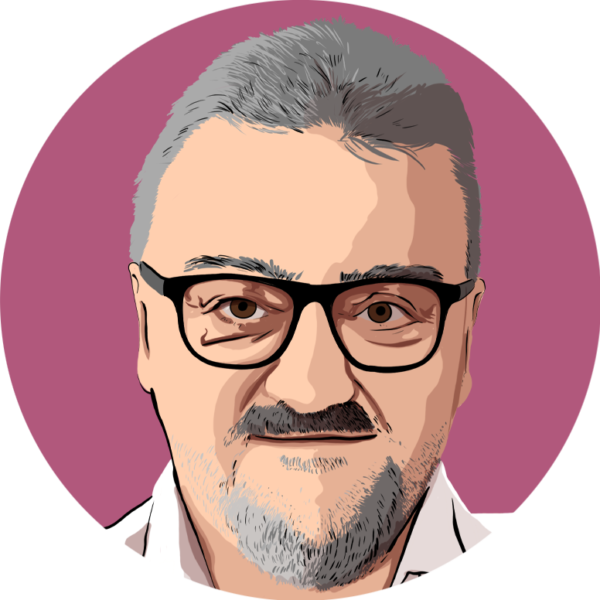 Roberto Castaldo - DFI Books
Roberto Castaldo - DFI Books