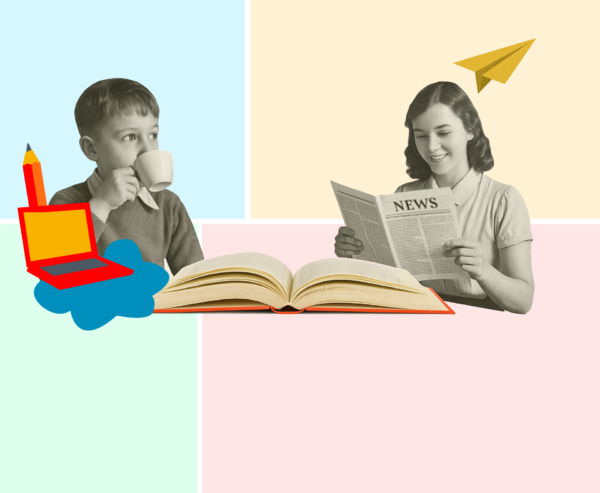Sono passati ormai diversi anni da quando ho introdotto nella pratica didattica, che costruisco insieme ai miei studenti, la metodologia di lavoro che ho imparato a conoscere partecipando con le classi al concorso nazionale di filosofia Romanae Disputationes.
La proposta di affrontare un concetto-problema chiave, capace di intercettare i nodi e le convergenze che la storia del pensiero occidentale (e non solo) ha generato nel corso del suo cammino, unisce sia la prospettiva storica che quella più propriamente tematica e concettuale.
Sfidare gli studenti a dire qualcosa di nuovo su problemi che da sempre sono il significante di una profondità i cui confini continuano a essere non tracciati, offre sia al docente che alle classi la possibilità di interrogarsi seriamente su cosa significhi pensare.

Mettersi alla prova con la scientificità
Volendo sintetizzare si potrebbe sostenere che sfidare gli studenti a produrre un elaborato filosofico che rispetti in modo rigoroso i criteri che la comunità dei professionisti del settore si è data per riconoscere l’originalità e la scientificità di uno scritto, apre tre possibilità che diversamente rischiano di rimanere nell’oblio.
1. Sperimentare cosa significa adottare un metodo scientifico per realizzare il proprio elaborato, imparando a seguirlo in tutte le sue fasi: dalle ricerche preliminari, agli approfondimenti bibliografici, alla suddivisione dei compiti all’interno del gruppo di lavoro. La classe ha partecipato in presenza alla lezione inaugurale del concorso, tenuta ogni anno da un docente universitario di rilievo nazionale. Successivamente è stata divisa in gruppi di lavoro che hanno in primo luogo il compito di suddividere tra loro la visione dei video di approfondimento messi a disposizione dall’organizzazione del concorso, così che ogni studente possa poi riportare quanto appreso ai compagni. Segue un lavoro di analisi di tutte le possibili interpretazioni del tema proposto che presuppone, ovviamente, anche un approfondimento a livello bibliografico, sempre intrecciando lavoro individuale con lavoro di squadra. In tutte queste fasi la regia del docente è fondamentale per appianare eventuali difficoltà nella collaborazione ed evitare la dispersione delle energie in ricerche inutili e fuorvianti, segnalando gli strumenti di ricerca e approfondimento bibliografico più adatti.
2. Comprendere la differenza tra avere un’opinione e avere un pensiero. Nel corso del lavoro di ricerca i gruppi sperimentano sia la vastità del campo di ricerca che ogni problema filosofico apre, sia la stratificazione e la complessità che caratterizza ogni singola interpretazione di ogni singolo concetto. Per facilitare questo processo inserisco di solito in parallelo al lavoro dei gruppi un torneo di disputa filosofica regolato da topoi (cioè argomenti) inerenti al tema su cui si sta lavorando. In questo modo il lavoro di analisi dell’argomento e di preparazione delle argomentazioni per la disputa, funge da incentivo ad andare a fondo delle diverse possibilità interpretative attraverso cui il tema di studio può essere letto.
3. Passaggio dalla dispersione al lavoro di scavo verso la profondità. Proprio grazie al lavoro di ricerca iniziato studentesse e studenti comprendono, attraverso un’esperienza autentica, come le “cose” diventino sempre più complesse e interessanti non appena si esce dallo schema domanda-risposta, abbandonando la sfera dell’ovvio e cominciando a dialogare con lo stesso linguaggio che si usa per porre la domanda. Questa esperienza si concretizza nel lavoro di scrittura collettiva dell’elaborato, attraverso le fasi di suddivisione del lavoro di scrittura e poi di armonizzazione e correzione collettiva di quanto prodotto singolarmente.

Un’esperienza autentica
Ritengo fondamentale sottolineare un aspetto: questi punti che ho appena evidenziato non accadono se ci si limita a seguire un programma o una formula, se così fosse infatti si tratterebbe semplicemente di una tecnica didattica che, da sola, risulterebbe completamente vuota a priva di desiderio.
Si tratta di un’autentica esperienza e, in quanto tale, non accade semplicemente perché la si è programmata, non si può progettare se non si comprende cosa significhi viverla per davvero.
Questa esperienza accade solo se la libertà del docente si relaziona a quella degli studenti all’interno di una comunità dove ci si prende cura delle domande, dei dubbi, delle intuizioni, degli errori, delle incomprensioni, delle incompatibilità di carattere, dei fantasmi personali, insomma di tutto ciò che “l’aggrovigliata trama dell’umana esperienza” (Cassirer) porta con sé, generando ogni volta possibilità inedite che occorre, però, essere disposti ad in-contrare.
Una sfida e una possibilità
Risulta pertanto chiaro che il primo passo deve necessariamente prendere le mosse dalla disponibilità del docente a lasciarsi provocare dalla proposta di lavoro che le Romanae Disputationes offrono, accettando di correre i “rischi” che ogni esperienza porta con sé. Tra questi spicca sicuramente la richiesta un congruo numero di ore curricolari e di un altrettanto nutrito di numero di ore extra-curricolari, lasciando da parte l’ossessione per il completamento del programma e per le verifiche di tipo tradizionale. Sarebbe pertanto importante che il docente non fosse da solo ad affrontare questo percorso ma fosse inserito in una comunità che rimanga sempre in cammino.

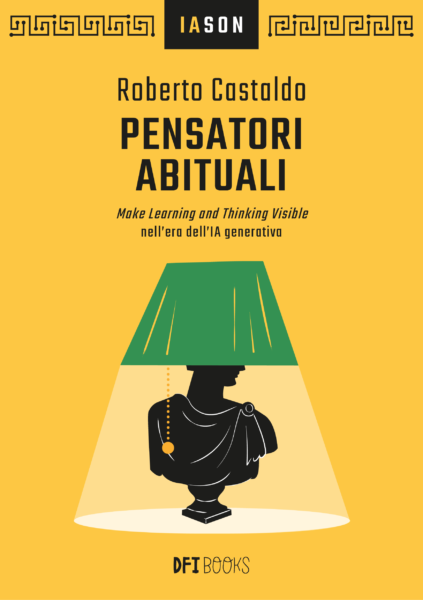





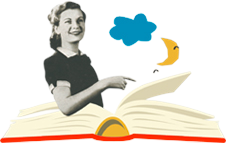

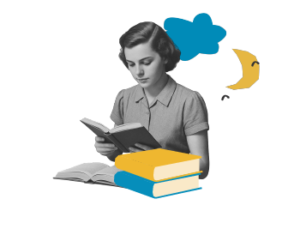


 Fabio Campinoti
Fabio Campinoti 





 Giuliana Disanto
Giuliana Disanto 
 Angela Schisa
Angela Schisa 

 Marta De Marinis
Marta De Marinis 
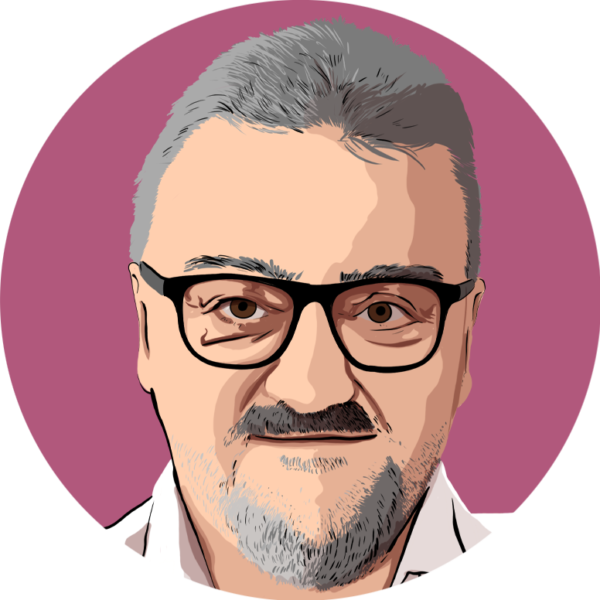 Roberto Castaldo - DFI Books
Roberto Castaldo - DFI Books